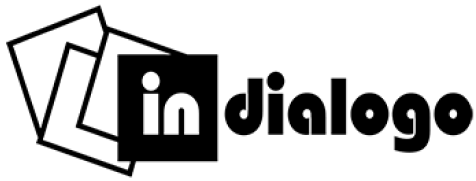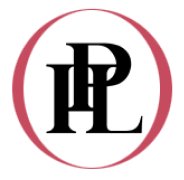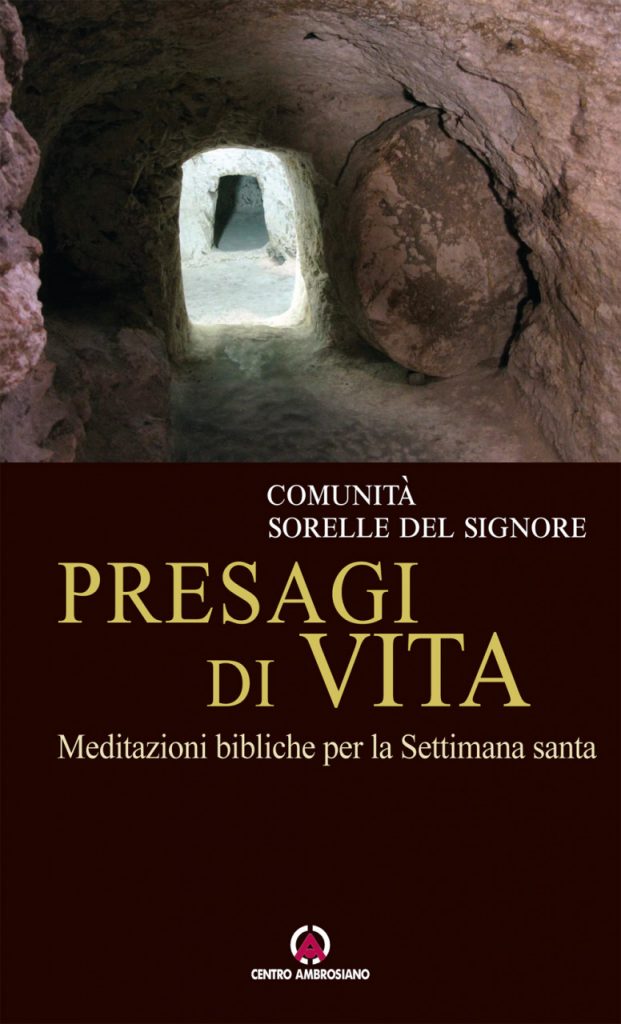State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano […]. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo. (Lc 21,34.36)
Il capitolo 21 del Vangelo secondo Luca si chiude così, prima dell’inizio della passione. Gesù è ormai a Gerusalemme da un po’ di giorni – il Vangelo non chiarisce quanti – ma lo troviamo stabilmente nel tempio a insegnare: durante il giorno insegna e di notte esce dalla città per pernottare all’aperto sul Monte degli Ulivi. E questo ci fa comprendere come il Monte degli Ulivi, e in particolare il Getsèmani, fossero per Gesù e i suoi discepoli luoghi conosciuti, ospitali anche più della città stessa, nonostante vi fosse stato da principio accolto con grande onore ed entusiasmo. L’insegnamento di Gesù affronta le prospettive escatologiche, legate alla fine dei tempi, mentre torna ricorrente un invito: vigilate! State attenti! Rileggendo le sue parole, ci ritroviamo facilmente negli “affanni della vita” di cui parla, quelle preoccupazioni cui permettiamo di appesantirci il cuore, di toglierci la serenità. Sono quelle che viviamo in prima persona oppure che colpiscono persone che ci sono care, conoscenti. Persone vicine oppure lontane, anche fisicamente, e per questo difficili da raggiungere. Due “pesi” diversi: il peso leggero, quello di Gesù, e il peso che preme sul cuore e che ci fa vedere ogni cosa come un macigno che piomba all’improvviso, senza darci il tempo per prepararci o per schivarlo.
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza… Gesù non vuole dire che dobbiamo passare il tempo pregando… ci vuole solo ricordare che vigilanza e preghiera sono due dinamismi intimamente connessi: la preghiera (che è relazione con Gesù) ci mantiene attenti a quello che capita dentro di noi e attorno a noi, e la vigilanza è un modo di abitare la vita senza sprecare nulla, senza lasciare nulla al caso. Se non separiamo vigilanza e preghiera, se non abbassiamo la guardia del cuore, allora avremo la forza, non la forza di superare le difficoltà a uno schiocco di dita ma avremo la forza di trasformarle in peso leggero. Un peso buono, non inutile, non fine a se stesso.
Ci consola sapere che Gesù affronta questi argomenti non come uno che predica agli altri da una posizione comoda, di privilegio, ma come chi ci ha preceduto e sempre ci precede attraverso gli affanni della vita. Nei prossimi giorni entrerà e uscirà di nuovo da Gerusalemme e noi, dietro di lui, arrancando un po’, cercando di volergli bene, nella fatica a comprendere, nel desiderio che arrivi preso un’alba migliore, l’alba di risurrezione. Lo ha promesso.
Come un chicco di grano
Per spiegare il significato della sua morte ai discepoli, Gesù ricorre a una breve parabola: «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). L’immagine del seme ricorre spesso: i Vangeli sinottici attestano che Gesù l’ha ripresa più volte per raccontare il mistero del Regno dei cieli (cfr. Mc 4,26-29; Mt 13,31-32) e quello della sua Parola (cfr. Mt 13,3-8). Qui, nel Vangelo secondo Giovanni, la utilizza per parlare di sé e del mistero pasquale, sorgente e origine della Chiesa. Gesù si identifica con il chicco di frumento che deve rimanere nascosto nel buio della terra e “morire” allo stato di seme per germogliare e portare frutto abbondante: «Ciò che tu semini non prende vita, se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere […] così anche la risurrezione dei morti: è seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge nella gloria» (1Cor 15,37.42-43).
Nel leggere la piccola parabola del chicco spontaneamente la nostra attenzione si concentra sul verbo “morire”: se il chicco non muore, se invece muore. Tuttavia, a livello grammaticale, la frase è retta da altri due verbi – “rimanere solo” e “produrre frutto” – che orientano la nostra riflessione sulla vita, quotidiana ed eterna. Gesù, con le parole sul chicco di grano e con quelle del versetto immediatamente successivo − «chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna» (Gv 12,25) −, ci invita a riflettere su due diversi modi con cui possiamo scegliere di gestire la nostra esistenza. Chi conserva gelosamente la propria vita, non la dona, la trattiene per sé, alla fine la perde perché rimane da solo. Non germoglia, proprio come il seme che, se non viene piantato nella terra, rimane soltanto un granello infecondo: non si manifesta in pienezza, non raggiunge il fine per cui è stato creato. Chi, invece, odia la propria vita, chi «non si attacca» a essa, vive l’esistenza nel dono di sé: non cerca di autoaffermarsi, di conservare e salvare se stesso, ma considera la propria vita preziosa per altri e la offre con amore seguendo l’esempio di Gesù, per essere con lui e servirlo (cfr. Gv 12,26). Chi agisce così, spesso lo fa in modo umile e nascosto, attraverso gesti semplici di ordinaria e gratuita dedizione, di cura, di ascolto. Dona senza misura e senza timore di sprecare tempo, energie e beni. Gesù ci insegna che colui che “perde” in questo modo la propria vita, in realtà, la conserva: conduce un’esistenza feconda e piena, sperimenta la gioia della comunione e porta il frutto che Gesù desidera, quello che rimane per la vita eterna (cfr. Gv 15,16).
(Tratto da: Comunità Sorelle del Signore, Presagi di vita, Centro Ambrosiano)