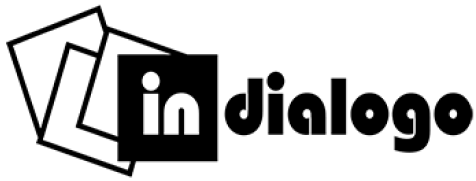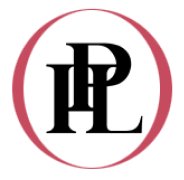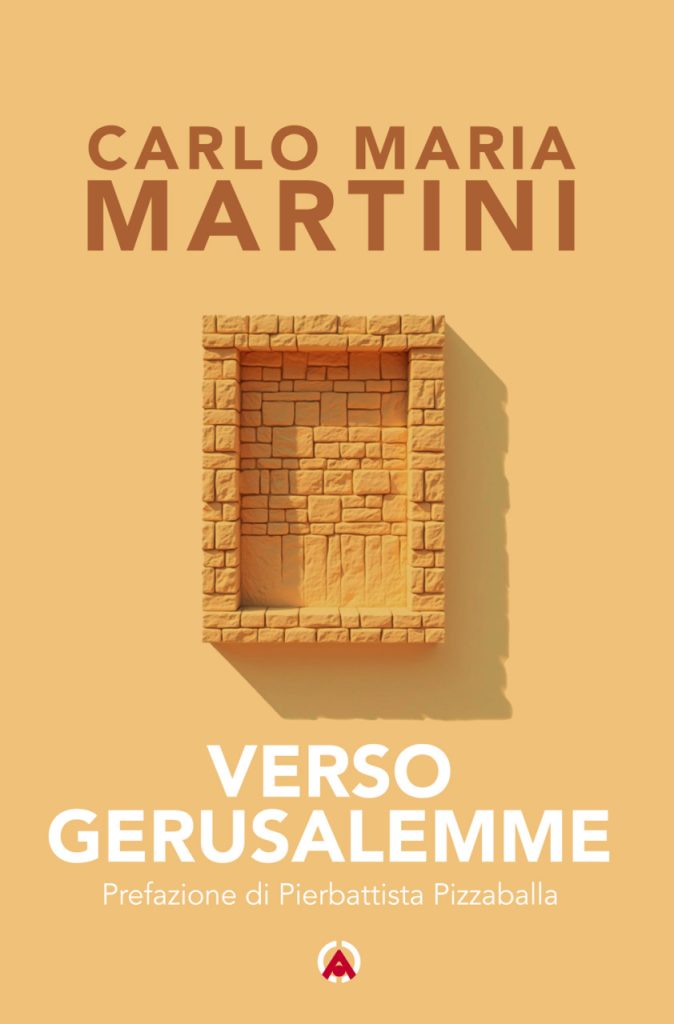Il passaggio di Gesù da questo mondo al Padre
«Sapendo Gesù che era venuta la sua ora per passare da questo mondo al Padre» (Gv 13,1). Vorrei cercare ancora i luoghi di transizione, i guadi di Gesù.
Gesù preannuncia il suo passaggio al Padre e Giovanni ce lo fa recepire nei gesti e nelle parole del Signore. Vive, per così dire, misticamente tale passaggio con il simbolo della lavanda dei piedi e con il simbolo del pane e del vino donati: simboli che si richiamano a vicenda e che terminano con il comando di ripetizione («Fate anche voi come ho fatto io, fate questo in memoria di me»).
Quali altri passi del Nuovo Testamento alludono al passaggio di Gesù? Uno lo leggiamo nel medesimo contesto: «Sapendo che il Padre aveva messo tutto nelle sue mani e che da Dio era uscito e a Dio ritornava» (Gv 13,3). Si tratta di un venire e di un ritornare. Ricordiamo, inoltre, Lc 9,31: «Mosè ed Elia parlavano con Gesù dell’esodo che stava per compiere a Gerusalemme». Il passaggio è dunque un esodo. Nel racconto dell’ultima cena è chiamato “partenza”: «Il Figlio dell’uomo parte, come è stato decretato» (Lc 22,21). Il medesimo concetto è espresso nelle tre profezie della passione con i vocaboli «passione», «morte», «risurrezione», che sono sempre menzionati eccetto che nella seconda predizione di Luca dove si parla oscuramente solo della «passione».
Allusioni più frequenti occorrono nel quarto Vangelo. Molto importante è Gv 10,17 perché è connesso con il servizio del pastore: «Per questo il Padre mi ama, perché io do la vita, per riprenderla di nuovo». Il passaggio è indicato come un dare la vita e riprenderla, ed è caratteristica propria del buon pastore.
Gv 12,23-25 esprime il passaggio come la sorte del grano di frumento caduto per terra, che muore e porta frutto, ossia un perdere la vita per ritrovarla: «È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In verità in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna». Ritorna ancora il tema in Gv 17,13: «Ora vengo a te e queste cose dico mentre sono nel mondo». Parole che ritornano nell’appello del Risorto alla Maddalena: «Va’ e di’ ai miei fratelli: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”» (Gv 20,17b).
Riassumo le immagini dei diversi brani: «passare dal mondo al Padre» significa concludere l’esperienza terrena verso l’esperienza definitiva; significa compiere l’esodo, passare dalla schiavitù alla libertà; in linguaggio biologico ed escatologico insieme, significa morire come il seme per poi risorgere. Ma abbiamo visto anche un’altra linea di immagini, quella del dare la vita e riprenderla, l’esperienza del martirio, dell’eroismo di chi offre la vita; come pure un altro tipo di linguaggio: umiliazione e glorificazione, passare dall’umiltà alla gloria.
A me pare che tutte queste metafore sottolineino come il passaggio nodale dell’esistenza umana non è tanto il morire biologico, bensì il prendere in mano la propria vita come un tutt’uno per donarla in un gesto simbolico, mettendola sull’altare. Gesù esprime questo gesto, che non solo anticipa il momento supremo della morte e ne vive la forza di sacrificio e di espiazione, ma dice anche la sintesi e l’intenzione di una vita intera. È l’opzione fondamentale, è – nel linguaggio degli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola – l’ultima preghiera della «contemplazione per ottenere l’amore»: «Prendi e ricevi, Signore, tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza». È l’opzione che raccoglie i frammenti della nostra vita unendola al passaggio di Cristo al Padre, al gettarsi del seme nella terra, al pastore che dona la vita. Il buon pastore è colui che compie il passaggio di offrire la vita per le pecore, e Gesù è questo pastore. Tale passaggio è per noi la decisione di dedicare a Dio l’intera nostra esistenza in maniera indivisa.
Carlo Maria Martini
(Tratto da: C. M. Martini, Verso Gerusalemme, Centro Ambrosiano)