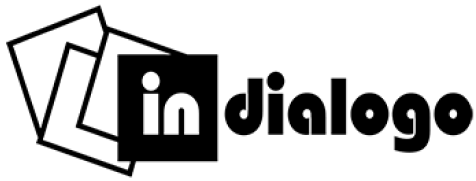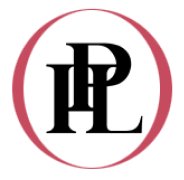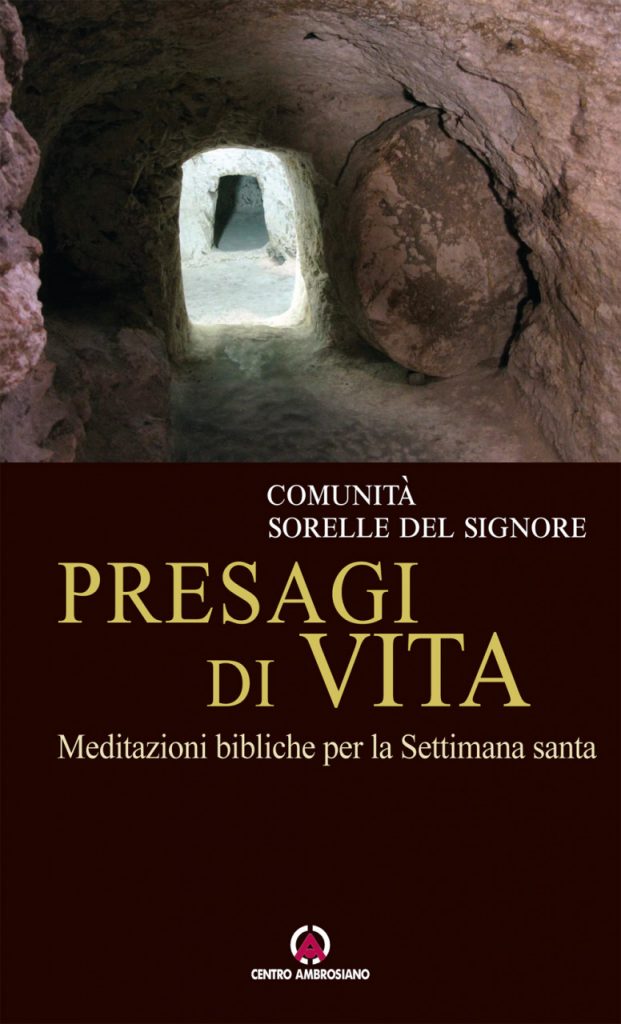La discesa dal Monte degli Ulivi: passi di libertà e liberazione
L’importanza dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme appare da una prima osservazione molto semplice, immediata: tutti e quattro gli evangelisti si preoccupano di raccontare questo episodio dai tratti misteriosi, che allarma le autorità e, allo stesso tempo, infiamma i cuori dei discepoli (cfr. Mt 21,1-11; Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; Gv 12,12-16). La liturgia pone questo episodio al principio della Settimana santa, la domenica precedente, anche se la distanza temporale tra l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e l’inizio della passione non è la stessa nei quattro racconti evangelici. Noi rimaniamo nel solco del racconto secondo l’evangelista Marco, autore di quella che è considerata la testimonianza più antica.
Il contesto
L’ingresso nella Città santa conclude una giornata molto lunga per Gesù, che Marco ha iniziato a raccontare al capitolo 10. Le parole del Maestro sono sempre più dure da ascoltare, incomprensibili, e chi lo segue comincia a provare paura e sgomento: Gesù ha annunciato per la terza volta, apertamente, il destino di passione e morte che lo attende a Gerusalemme. Ed è proprio Gerusalemme la meta del cammino che ha intrapreso insieme ai suoi discepoli. Sono partiti dalla Galilea, da Cafàrnao, e hanno preso la strada che costeggia il fiume Giordano perché garantisce l’accesso all’acqua, nonostante ci sia deserto tutto attorno. Così, percorrendo la valle dell’Araba, si arriva a Gerico e da lì si comincia la salita verso ovest, verso Gerusalemme, attraversando il deserto di Giuda. La giornata terminerà con l’ingresso nella Città santa e nel tempio.
Per Marco, quello dell’ingresso a Gerusalemme è il primo di sei giorni, e non è difficile trovare in questa annotazione temporale il richiamo al racconto della creazione. Si apre la settimana di una nuova creazione e il primo giorno, come fu per la creazione primordiale, è giorno di luce che abbraccia tutti gli avvenimenti che di lì a poco si susseguiranno. Non è un caso che nella liturgia di rito romano, nella Domenica delle Palme venga letto per intero il Vangelo della passione. Questo è il giorno nel quale è necessario preparare i sentimenti: come Gesù e i suoi discepoli, potremmo essere arrivati a questa settimana con qualche fatica nelle gambe e qualche pesantezza sul cuore. Ora bisogna sostare sulla cima del Monte degli Ulivi, tra Betània e Betfage: l’ultimo tratto di strada non si compie per inerzia.
All’inizio del Vangelo, Marco aveva posto una citazione profetica che, riprendendo parole di Isaia e Malachia, annunciava la venuta del messaggero – voce di uno che grida nel deserto – per preparare la via. Ma se proseguiamo nella lettura del versetto della profezia di Malachia, troviamo un’altra indicazione importante: «Subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate» (Ml 3,1). L’ingresso di Gesù a Gerusalemme è stato preparato da lontano: il mistero dell’incarnazione del Verbo di Dio, che percorre sottotraccia tutto il racconto evangelico, sta arrivando al suo compimento. Gesù non entra nella Città santa e nel suo tempio come aveva fatto molte altre volte negli anni, ora vi entra da re… un re molto particolare.
Betfage
Prima di arrivare a Gerusalemme, Gesù si ferma su una delle cime del Monte degli Ulivi, dove si trova il villaggio di Betfage, che al tempo era il luogo in cui si sostava per la purificazione prima di calpestare il sacro suolo della Città santa e del tempio in particolare. C’è qualcosa d’altro che Gesù intende purificare, ed è l’idea stessa di “Messia” che i suoi discepoli, proprio come tutto il resto del popolo d’Israele, attendevano nell’armatura di un condottiero militare. Si attarda: sosta all’esterno della città e prepara il suo ingresso coinvolgendo i discepoli anzitutto, e poi la folla. Nulla appare casuale: tutto è predisposto secondo i piani del Signore. Gesù dà indicazioni ai discepoli ed essi trovano tutto come previsto (il puledro si trova dove deve trovarsi, la gente lascia fare…): è come se tutto rispondesse ai piani del Signore, ma nella forma della partecipazione, non in quella della pura esecuzione di un comando. Perché il disegno di Dio si compia, ciascuno deve fare la sua parte… gli uomini ma anche la natura rappresentata da un puledro d’asina, cui spetterà il giogo leggero di portare il Figlio di Dio verso il compimento della sua missione. L’ingresso di Gesù a Gerusalemme appare, allora, come una grande liturgia: la venuta del Messia è manifestata a tutti gli uomini.
Un puledro da slegare
La prima parte del racconto ha come protagonista un “puledro”, termine che richiama la profezia di Zaccaria (cfr. Zc 9,9): non è la prima volta che Dio sceglie ciò che agli occhi degli uomini è piccolo e fragile per realizzare il suo disegno. Gesù manda due dei suoi discepoli a cercare un puledro, un asino diremmo noi più familiarmente, al quale assegniamo per consuetudine dei compiti ben definiti. L’asino porta i pesi degli altri, è l’animale umile del servizio quotidiano, sa semplicemente cosa deve fare e lo fa. Esattamente come farà Gesù sulla croce, che porterà il peso dei nostri peccati. L’apostolo Paolo, nella lettera ai Galati, scriverà: «Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo» (Gal 6,2). Ma qual è la legge di Cristo? È quella dell’amore, e quando uno ama veramente, si pone in una logica di servizio nei confronti dell’altro. L’asino è allora il simbolo della disponibilità a portare i pesi gli uni degli altri: è la qualità divina dell’amore inscritta in ogni uomo, in quanto Figlio di Dio.
Gesù anticipa altre due caratteristiche del puledro che i discepoli devono condurre: è legato e su di esso nessuno è ancora salito. La “legatura” condensa in un’immagine molto efficace tutto ciò che ostacola il movimento, il cammino. Dove piedi e cuore sono strettamente connessi. E sono anzitutto ostacoli che si frappongono tra noi e la pratica dell’amore: ostacoli interiori, come la paura e l’egoismo, ma anche inciampi esterni, magari connessi all’ambiente in cui viviamo e nel quale è obiettivamente difficile vivere il Vangelo nella libertà. Da queste legature possiamo provare a liberarci da noi stessi, ma sappiamo bene che non è sufficiente e che da soli non siamo capaci. Per questo Gesù comanda (e non può che tornarci alla mente la risurrezione di Lazzaro) di slegare il puledro. Portare Gesù sulla groppa è un cammino di libertà, anche se poi l’animale verrà restituito al suo legittimo proprietario.
Inoltre, Gesù ci fa sapere che quel particolare asino non è mai stato cavalcato da altri… sarà Gesù stesso il primo a farlo. Gesù traccia una via nuova, insegna un modo nuovo di amare, alla maniera di Dio, di un Dio che assume la vulnerabilità umana e, per amore, si consegna al giudizio di altri. Nessuno lo avrebbe ritenuto possibile. C’è un’altra possibile sfumatura: secondo la Legge di Mosè, gli animali destinati al culto non dovevano aver portato il giogo (cfr. Nm 19,2; Dt 21,3): questo piccolo puledro collaborerà così alla liturgia per l’arrivo del Messia nella Città santa portando il Salvatore.
Gesù comanda dunque di slegare il puledro e di portarlo da lui: la liberazione (risuonano qui le parole della profezia di Is 61,1-2) è in vista di un compito. Il puledro non viene liberato e lasciato a se stesso, ma condotto da Gesù. E Gesù previene la perplessità del proprietario del puledro e forse degli stessi discepoli e spiega di averne bisogno: «Se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno”». Questo è l’unico testo in cui Gesù chiama se stesso “Signore”, ed è anche l’unico testo nel quale Gesù dice esplicitamente di aver bisogno di qualcosa: ha bisogno di un asinello.
Tutto avviene in un lasso di tempo che appare molto breve, sottolineato dall’uso ripetuto dell’avverbio “subito”. Subito i discepoli troveranno il puledro e subito Gesù rimanderà il puledro nel suo villaggio. Gesù non perde tempo: è spinto da una sorta di urgenza divina. Ormai il suo destino di passione è all’orizzonte: intuisce con crescente intensità che il Padre sta per domandargli tutto. E lui non si tira in- dietro, non temporeggia. Al contrario. Con la medesima determinazione con cui aveva intrapreso il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme, così ora si appresta a varcare la soglia del tempio. Ogni cosa va fatta bene e va fatta subito.
Torna alla mente un altro ingresso di Gesù a Gerusalemme, raccontato nel capitolo 2 del Vangelo secondo Giovanni. In quell’occasione Gesù scacciò dal luogo santo i venditori di animali e i cambiavalute, che avevano trasformato il tempio in un’opportunità vantaggiosa per i loro commerci. I discepoli avevano collegato quella scena inusuale a un’espressione che si trova nel Salmo 69,10: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». C’è uno zelo che muove Gesù e che ha origine nel suo “rimanere nelle cose del Padre”. Così aveva spiegato ai suoi genitori il dodicenne Gesù, fermatosi nel tempio a Gerusalemme per interrogare i dottori.
Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Troviamo qui raccolti tutti i nostri “perché”, le domande sulle motivazioni ultime che provocano turbamento. Ci disorienta non poter collegare a ogni effetto la sua causa ultima. Così deve essere stato per i discepoli, per il padrone del puledro e per chi rimaneva a guardare. Dove troviamo il giusto equilibrio tra la comprensibile esigenza di sapere e l’affidamento alla parola di Gesù, chiara e perentoria ma avara di spiegazioni? Tocchiamo qui il nucleo di ogni scelta di fede, fondata su testimonianze ed evidenze, eppure ancora oscura, con lo sguardo proiettato in avanti, verso un compimento che ha ancora da venire. Ci sono domande senza risposta o, meglio, senza una risposta capace di sciogliere ogni dubbio, qui e ora. Seguiamo Gesù, sciogliamo ogni timore e ogni dubbio… ma siamo davvero sicuri che ne varrà la pena? Che, alla fine, troveremo ciò di cui andiamo in cerca?
Appare chiaro, allora, come l’episodio dell’ingresso a Gerusalemme, oltre ogni affettuoso richiamo alla processione degli ulivi che da bambini amavamo tanto, ci scaraventa letteralmente nel vivo della Settimana santa e – come i discepoli che entravano al seguito di Gesù – ci assale il sentimento dell’irreparabile, della perdita di controllo su tutto quello che accade e che sta per accadere. Sapremo fidarci della parola di Gesù? Ci basterà?
Non resta che assumere i tratti di un ignaro puledro, anche quando può sembrare fuori luogo e persino un po’ ridicolo. Perché al di là di ciò che siamo e di ciò che sembriamo, di ciò che pensiamo e di ciò a cui crediamo, al di là dei nostri dubbi e delle nostre insicurezze, il Signore “ha bisogno” anche di noi. Un proverbio arabo dice che l’asino del principe è il principe degli asini. Lasciamo dunque che Gesù salga sulla nostra groppa e ci introduca alla Città santa e al suo mistero: ci è dato un punto di osservazione che non ha eguali.
(Tratto da: Comunità Sorelle del Signore, Presagi di vita, Centro Ambrosiano)