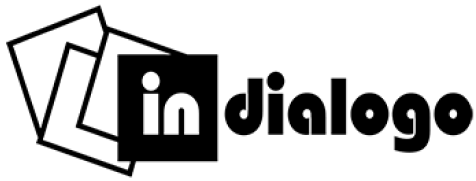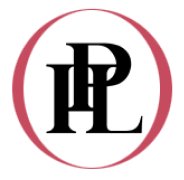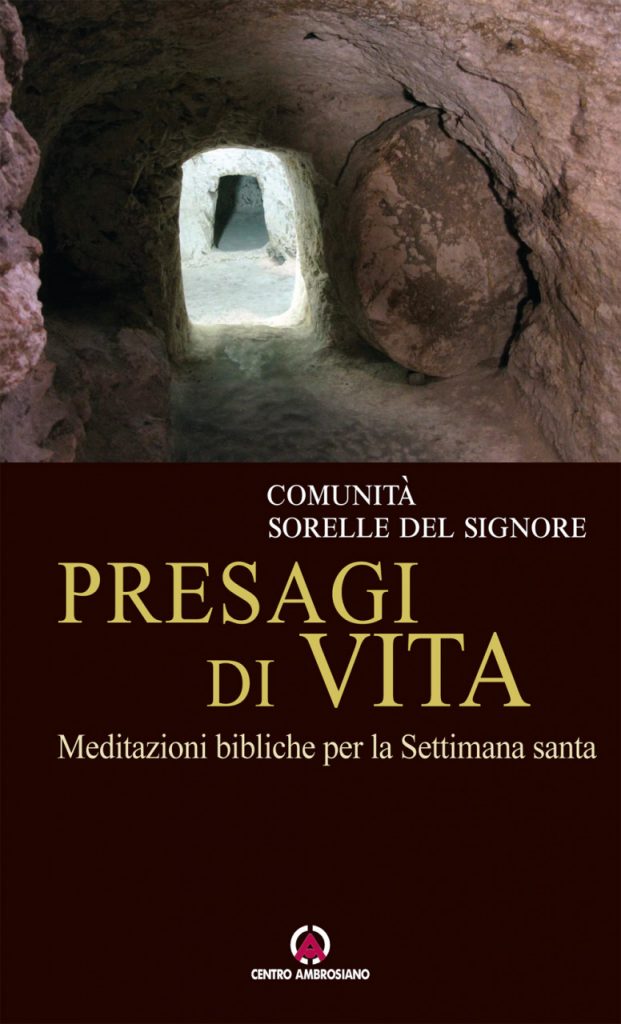Essere amici di Dio non preserva dalla complessità della vita, chiede al contrario di esporsi, di mettere a rischio la propria vita, di tendere sempre al superamento di sé, oltre ogni possibile mediocrità. Il Figlio di Dio, prediletto e crocifisso, porta a perfezione la figura del servo del Signore descritto nelle profezie di Isaia (cfr. Is 42,1-9). Eppure, potremmo rileggere le parole del profeta provando a mettere noi stessi nella scomoda posizione del servo del Signore, di colui o di colei che ha ricevuto un compito. Non si parla qui di vocazione, di uno stato di vita particolare, ma di un modo di abitare il mondo, di non essere (come diceva Paolo VI) estranei alla storia. E se riprendiamo in mano, parola per parola, il testo di Isaia ci accorgiamo di quanto il mondo abbia ancora bisogno di figure così, anonime forse, ma amate, prescelte e inviate. Certo… “portare il diritto alle nazioni” può sembrare compito sproporzionato alle nostre reali possibilità, al nostro ruolo nella società, ma gli atteggiamenti descritti sono in realtà molto semplici, feriali, alla portata di tutti: non alzare il tono, non strillare nelle piazze… in un tempo in cui la ragione sembra stare dalla parte di chi parla di più, di chi urla di più, di chi insulta di più… l’invito a non alzare il tono è estremamente attuale, forse un po’ rivoluzionario e comunque controcorrente. Non spezzare una canna incrinata, non spegnere una fiamma smorta… in un tempo in cui vige la legge del più forte… proteggere i più deboli è diventato un lusso, roba da ingenui idealisti. E poi proclamare il diritto con verità… che potremmo sintetizzare semplicemente “dire la verità”: basterebbe così poco per portare il diritto alle nazioni? Forse no, ma sarebbe un ottimo punto di partenza. Ma dire la verità non va molto di moda. Oggi ci è chiesto di contemplare Gesù – amato e crocifisso – capostipite degli amici di Dio ai quali è riservata una sorte complicata, che spinge decisamente verso un oltre, oltre noi stessi, oltre le nostre paure, oltre i nostri limiti. San Paolo direbbe che è la grazia a caro prezzo, noi aggiungiamo che è una vita pienamente umana ma abitata dallo spirito di Dio, dal Creatore di tutto che ci prende per mano.
Eccesso di amore, eccesso di dolore
Tutta la vita di Gesù deve essere intesa come un cammino verso la croce, orizzonte a cui, nella libertà e per amore, il Figlio si è reso obbediente (cfr. Fil 2,8). La morte di Gesù apre alla nostra meditazione il mistero della kenosi, cioè dello svuotamento di sé, la cui prima manifestazione è l’incarnazione. Dal mistero dell’Annunciazione, della Nascita, alla fine della sua vita, tutta l’esistenza umana di Gesù di Nàzaret è all’ombra della croce. Dietro questo svuotamento di sé e abbassamento della sua vita c’è il desiderio ardente di Gesù di vivere “sapendo il Golgota”, conoscendo cioè fin dall’inizio la via e la strada che, passando attraverso l’amore per l’uomo, lo porterà a scegliere di morire per l’uomo che ama, scelta che racconta la misura del divino amore. Gesù sa che la sua morte è la misura della sua esistenza. Gesù vive fin da principio in vista dell’Ora: dalla distanza di questa, misura ogni sua azione (cfr. Gv 2,4; 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1; 16,32; 17,1). La croce, che egli non anticipa e la cui conoscenza rimette al Padre (cfr. Mc 13,32), è la misura della sua esistenza. Di fronte a questo smisurato amore di Dio, che non conosce neanche il limite della morte, si delinea l’altro eccesso che la passione ci fa vivere: un eccesso di dolore e sofferenza, di cattiveria umana, un eccesso di ingiustizia. La passione ci pone in mezzo a queste due sconfinate misure che lacerano l’animo del credente che desidera pregare e meditare la morte di Gesù. Due eccessi inconciliabili, il dolore e l’amore, tenuti insieme dal braccio della croce che unisce gli opposti nell’unità del cuore di Cristo, Amore offerto e consegnato, che fa della morte il più alto luogo di amore. La croce, passando attraverso il dolore della morte, apre a un eccesso di amore e di trascendenza: un amore che non si può né comprendere né descrivere, qui tutto non è solo umano, ma umano-divino, ciò che avviene lascia trasparire e ci fa intravedere qualcosa del Mistero ineffabile, del Mistero trinitario.
(Tratto da: Comunità Sorelle del Signore, Presagi di vita, Centro Ambrosiano)